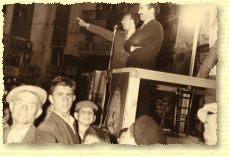|
|
|||||||||
|
Politico e Poeta d'altri tempi |
|||||||||
Le adesioni crebbero a valanga. Accanto al partito socialista operavano le cooperative dei cavamonti, dei muratori e quella per la vendita dei generi alimentari.
Dal
1946 al ‘56, il professore consumò le sue più grandi battaglie
politiche, contro i monarchici, i neo-fascisti, i democristiani. Fu, più
volte, Consigliere Comunale e, naturalmente, Capogruppo in Consiglio;
divenne anche Consigliere Provinciale. Fece crescere il PSI sino a
raggiungere il numero di 11 Consiglieri Comunali. Convinto che
l’emancipazione delle classi popolari passasse per un’alleanza con
quelle borghesi, aprì il partito, anche contro la volontà di alcuni
compagni operai, ai cc.dd. «colletti tesi».
Memorabili
gli affollatissimi «comizi» tenuti nella Piazza «Rossa» (Repubblica),
ma non solo ad Altamura. Matera, Gravina, Poggiorsini, Spinazzola,
Minervino, Grassano, Palazzo S. Gervasio, Corato, Ruvo, Toritto ed altri
paesi limitrofi, fecero a gara per contendersi la presenza dell’ormai
famoso oratore, del trascinatore di popolo, i cui comizi terminavano
inevitabilmente con una festa: bande, fuochi d’artificio, e
l’immancabile «inno dei lavoratori».
Nel
biennio ’46 – ’48, l’intero Paese fu scosso da grandi tensioni. La
«guerra fredda» era già iniziata. Gli americani, da un lato, e
l’URSS, dall’altro, avevano cominciato a far sentire la loro
influenza. All’interno del partito, l’atavico dibattito tra
massimalisti e riformisti suscitò grandi contrasti sulla linea da
seguire. Giuseppe Saragat ed il gruppo degli «autonomisti» (corrente
minoritaria) puntarono sull’Occidente. I «fusionisti», guidati da
Pietro Nenni, puntarono, invece, sul patto di unità d’azione con i
comunisti. Al congresso celebratosi nel gennaio del ’47, lo scontro causò
la scissione. Il gruppo di Saragat fondò il Partito Socialista dei
Lavoratori Italiani (PSLI), che in seguito (1952) diventò Partito
Socialista Democratico Italiano (PSDI), disponibile a collaborare con la
DC nel governo del Paese. L’altra ala del partito confluì nel Fronte
democratico popolare, che, al termine di un’aspra campagna elettorale,
perse le elezioni politiche del 18 aprile ’48.
Le ragioni della protesta erano note a tutti: nel Sud della penisola esistevano proprietà sterminate in gran parte rimaste incolte, mentre contadini ed esponenti dei ceti più deboli sopravvivevano a fatica. Comunisti, socialisti e CGIL guidavano scioperi ed occupazioni, ma, a volte, la protesta montava da sola.
Furono
anni di grandi battaglie anche qui sulla Murgia. Il prof. De Lucia, con la
sua oratoria fiammeggiante, non si sottrasse allo scontro. Fece sentire la
sua voce nelle piazze, nei luoghi istituzionali, ma anche attraverso i
suoi scritti. In un articolo pubblicato in quel periodo, invocò a gran
voce la riforma fondiaria, denunciando lo scandalo di 22mila ettari di
terra in mano ad appena 90 famiglie e ponendo l’accento sulla
maturazione del movimento bracciantile.
In
particolare, scrisse: «Gli scioperi del ’45, ’46, l’occupazione
delle terre del ’49 e ’50, le vittorie elettorali amministrative e
politiche che hanno avuto il crisma della fusione delle forze contadine
con quelle artigiane sono una prova dell’avvenuta coscienza di classe.
Il male, è vero, è ancora trincerato nella roccaforte delle novanta
famiglie che posseggono oltre 22mila ettari di terra, ma è vero pure che
le forze del bene in nome delle settemila famiglie contadine senza un
palmo di terreno non danno tregua all’avversario.» pag. 2 di 7
|
|||||||||
|
A
mio padre
|